Questa sezione ospita soltanto notizie d'avvenimenti e produzioni che piacciono a me.
Troppo lunga, impegnativa, certamente lacunosa e discutibile sarebbe la dichiarazione dei principii che presiedono alle scelte redazionali, sono uno scansafatiche e vi rinuncio.
Di sicuro non troveranno posto qui i poeti lineari, i pittori figurativi, il teatro di parola. Preferisco, però, che siano le notizie e le riflessioni pubblicate a disegnare da sole il profilo di quanto si propone questo spazio. Che soprattutto tiene a dire: anche gli alieni prendono il taxi.
lunedì, 25 novembre 2024
Se il fascismo va di moda (1)=
Pubblicato dalla casa editrice Futura presento oggi un libro che non è soltanto scritto bene ma ha anche il grande merito di essere necessario visti i tempi che stiamo vivendo.
Titolo: Se il fascismo va di moda L'estremismo di destra e i giovani.
Le autrici sono Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo.
Ghiglione è coordinatrice della Segreteria Generale e responsabile delle Politiche di genere della Cgil nazionale (in passato ha guidato la Camera del Lavoro della Spezia). Docente, laureata e specializzata in Criminologia, è autrice di numerosi articoli e di due saggi: “Così parlano le mafie, viaggio nei linguaggi mafiosi di ieri e di oggi” (Città del Sole, 2020) e “Corrotti. Dentro gli affari criminali di élite e mafie” (Armando Editore, 2021). Isoppo psicologa-psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia dell'approccio centrato sulla persona.
Già docente di Psicologia Generale all'Università di Genova, è specializzata inoltre in Problemi e Patologie Alcol-correlate e Scienze Criminologico-Forensi.
È stata già su Comosmotaxi presentando con il coautore Beppe Mecconi, Cronache dal Diana. Un antropologo dilettante in un cinema a luci tosse.
Per Futura insieme con Lara Ghiglione ha pubblicato anche Come farfalle nella ragnatela. Storie di ordinaria violenza digitale sulle donne.
Nata a Sarzana, vive e lavora a Roma. Scrive Paolo Berizzi nell’Introduzione: “Come si diventa fascisti nel terzo millennio? Perché il fascismo “tira” tra i ragazzi? È un fenomeno complesso da analizzare, e questo libro scritto da Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo ci aiuta a farlo, consentendo al lettore di entrare in possesso di un’adeguata cassetta degli attrezzi per capire in che modo tale fenomeno si compia. Gli ingranaggi del meccanismo, le leve psicologiche del consenso, il lievito madre della militanza”. Giuseppe Massafra nella Postfazione: “Il testo offertoci dal prezioso studio di Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo affronta uno dei temi più controversi e delicati di questa nostra epoca. Le preoccupazioni di una recrudescenza dell’ideologia fascista trovano spazio in episodi che la cronaca e alcune inchieste giornalistiche spesso raccontano e nel linguag-gio politico che pare abbia superato il pudore imposto dopo la tragedia del ventennio. Linguaggio e comportamenti oggi innervano la società e allettano, come ci spiegano le autrici, soprattutto le generazioni più giovani, tanto più lontane dalla storia passata, quanto più autentiche interpreti di un presente convulso”. In questo breve video alcuni ragazzi rispondono sul perché il fascismo va di moda. Dalla presentazione editoriale. 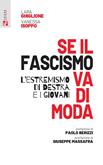 «Una gran quantità di giovani, nel nostro Paese, milita in movimenti che si richiamano alle ideologie nazifasciste. Si può ormai dire che l’estremismo di destra permea ogni ambito di vita e di interesse di un numero sempre più elevato di soggetti – moda, musica, volontariato, (anti)femminismo, sport, arte e persino cultura –, in un crescendo di “cieca militanza” dalla quale, una volta entrati, è difficile uscire. Un fenomeno pieno di contraddizioni che tendiamo a sottovalutare, nonostante il continuo ripetersi di gravi fatti di cronaca. Il libro di Ghiglione e Isoppo analizza dati ed elementi di questo consenso, le dinamiche di “affiliazione” e anche, per converso, l’impegno dei tantissimi esponenti delle nuove generazioni – veri e propri partigiani 4.0 – impegnati ogni giorno, troppo spesso nell’indifferenza degli adulti, a difendere la nostra democrazia e nel contempo a custodire i valori della Costituzione nata dalla Resistenza». «Una gran quantità di giovani, nel nostro Paese, milita in movimenti che si richiamano alle ideologie nazifasciste. Si può ormai dire che l’estremismo di destra permea ogni ambito di vita e di interesse di un numero sempre più elevato di soggetti – moda, musica, volontariato, (anti)femminismo, sport, arte e persino cultura –, in un crescendo di “cieca militanza” dalla quale, una volta entrati, è difficile uscire. Un fenomeno pieno di contraddizioni che tendiamo a sottovalutare, nonostante il continuo ripetersi di gravi fatti di cronaca. Il libro di Ghiglione e Isoppo analizza dati ed elementi di questo consenso, le dinamiche di “affiliazione” e anche, per converso, l’impegno dei tantissimi esponenti delle nuove generazioni – veri e propri partigiani 4.0 – impegnati ogni giorno, troppo spesso nell’indifferenza degli adulti, a difendere la nostra democrazia e nel contempo a custodire i valori della Costituzione nata dalla Resistenza».
Segue un incontro con Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo.
Se il fascismo va di moda (2)
Alle due autrici  Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo (in foto, a destra Ghiglione) ho rivolto alcune domande. Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo (in foto, a destra Ghiglione) ho rivolto alcune domande.
Le sentirete rispondere con una voce sola: prodigi della tecnologia di bordo su Cosmotaxi. Da quali esigenze è nato questo libro? L’idea del libro nasce per cercare di dare risposta a una serie di “campanelli d’allarme” che si sono susseguiti negli ultimi anni nel nostro Paese, culminati nell’assalto alla sede nazionale della CGIL, avvenuto a Roma il 9 ottobre del 2021. Alcuni esponenti di movimenti di estrema destra, infatti, cavalcarono il dissenso nei confronti di alcuni provvedimenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, per perpetrare un atto violento dal forte significato simbolico, visto che le Camere del lavoro vennero prese di mira e assaltate durante il periodo del fascismo “originario”. Non a caso il libero sindacato venne messo fuori legge e sostituito dal sindacato fascista. Oltre a questo, ci preoccupavano e ci preoccupano segnali e simboli che emergono nelle città, l’apertura di attività commerciali e locali gestiti da associazioni e partiti che si rifanno ai disvalori di estrema destra frequentati in particolare dai giovani, e alcuni ricorrenti aggressioni ai danni di ragazze e ragazzi che si dichiarano esplicitamente antifascisti. A fronte di questi segnali, che reputiamo preoccupanti, volevamo cercare di capire cause ed effetti dei neofascismi, attraverso un’analisi di carattere sociologica e criminologica.
Nel progettare il piano di scrittura di questo saggio, qual è la cosa che avete ritenuto assolutamente per prima da evidenziare e quale quella per prima assolutamente da evitare? Abbiamo voluto mettere in evidenza che, purtroppo, il fascismo non è morto e che le sue radici non sono così lontane da poterlo considerare ormai un fenomeno risolto. Anche nell’attuale maggioranza al governo del Paese sono presenti politici di orgogliosa origine fascista e riteniamo che il fatto che alcuni di loro lo rivendichino senza pudore o vergogna abbia indotto una sorta di normalizzazione, allontanando la consapevolezza che il fascismo sia da considerarsi “fuori legge” e come tale, quindi, andrebbe combattuto sia dai politici di sinistra che da quelli di destra; avendo giurato sulla Costituzione dovrebbero saperlo. A ogni presentazione, inoltre, chiediamo sempre a gran voce lo scioglimento di forze che si richiamano a simboli e disvalori nazifascisti, come CasaPound e Forza Nuova. Abbiamo cercato di evitare l’eccesso di faziosità, cercando di analizzare le dinamiche con il massimo della nostra onestà intellettuale, e vogliamo precisare che il nostro studio non vuole assolutamente stigmatizzare le giovani generazioni ma anzi coglierne difficoltà e disagi.
Penso che Craxi prima e Berlusconi poi siano responsabili della creazione di un ambiente psicosociale (esaltazione della ricchezza, della forza, del maschilismo, eccetera) favorendo la moda del “me ne frego”. Esagero? No. Di Berlusconi non possiamo non ricordare l’orgoglio con cui nel 2019 ha affermato di “aver portato i fascisti al governo, legittimandoli e costituzionalizzandoli”. Certo è che l’esaltazione di quella “Milano da bere”, tanto in auge in quel periodo, ha aperto la porta a ogni tipo di superficialità a discapito, appunto, dell’approfondimento e della riflessione. La cultura oggi è “fast” ci si informa (informa?) scrollando velocemente lo smartphone e là dove c’è sottocultura si crea l’humus ideale per le idee fasciste, un esempio su tutti la sovranità o la strenua difesa della famiglia “tradizionale”, o la mortificazione del ruolo della donna preferibilmente relegata all’espressione della maternità. Attribuite quali responsabilità al mondo democratico al permettere di concretizzarsi il fenomeno neofascista specie fra i giovani? Le responsabilità partono da lontano: scontiamo l’assenza di un corrispettivo italiano del processo di Norimberga, è mancato un processo ai gerarchi fascisti italiani con gli stessi capi d’imputazione dei nazisti: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini contro la pace. In Germania il cognome Hitler è completamente sparito, anche semplici omonimi, spinti dalla vergogna, hanno chiesto e ottenuto il cambio del cognome. In Italia agli orgogliosi discendenti di Mussolini la democrazia ha concesso di entrare in politica, e l’ignoranza ha permesso che venissero eletti. Avremmo forse dovuto essere “un po’ fascisti con i fascisti?”. No, ripudiamo il fascismo senza se e senza ma, ma certo non si doveva consentire la formazione di gruppi neofascisti come il già citato Forza Nuova, per esempio. Così come non sono consentiti partiti o gruppi politici di chiara ispirazione mafiosa. Il fascismo è un crimine al pari della mafia e quando lo si capirà sarà sempre troppo tardii? Se il fascismo oggi è una moda dovremmo avere, come accade a tutte le mode, anche il suo tramonto. É così? Oppure pensate che questa è una moda che non passerà troppo presto? Purtroppo, ci sono mode che non tramontano mai e se non alzeremo le nostre difese democratiche rischiamo di continuare ad assistere all’acquisizione di consenso da parte di partiti di estrema destra in tutto il mondo, come, purtroppo, sta già accadendo. Come agire affinché questa moda passi il prima possibile? Serve cultura, serve rivedere i programmi scolastici di storia, per esempio. La storia moderna viene affrontata, quando va bene, alla fine dell’anno della fine di ogni ciclo scolastico, in modo spesso veloce e superficiale. Bisognerebbe invece dedicare almeno il triennio delle scuole medie superiori ad approfondire questa parte così importante per comprendere gli orrori del passato e prenderne le distanze una volta per tutte. Ma, soprattutto, è assolutamente necessario dare risposte ai bisogni e ai diritti sociali e civili delle persone: i populismi e gli estremismi sono per loro natura movimenti antisistema e, come tali, si insinuano nel disagio e nel legittimo dissenso di chi fatica ad arrivare a fine mese. Soprattutto i giovani hanno diritto a prospettive di vita e di lavoro dignitose, presupposto che oggi in troppe e troppi non riescono a realizzare. Su questo, soprattutto, dovremmo investire. …………………………………….. Lara Ghiglione - Vanessa Isoppo
Se il fascismo va di moda
Prefazione di: Paolo Berizzi
Postfazione di: Giuseppe Massafra
138 pagine * 13.00 euro
Futura Editrice
giovedì, 21 novembre 2024
Saladino (1)
La casa editrice Graphe.it ha dedicato un volume della indovinata collana I Condottieri a una grande figura storica ammantata da storia e leggende che ne accompagnano la vita in un’aura grandiosa e terribile.
Titolo: Saladino Il sovrano cavaliere.
L’autore è un grande arabista: Roberto Celestre.
Ricercatore indipendente laureato in Lingua e Letteratura Araba con indirizzo storico all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Ha trascorso due anni al Cairo svolgendo corsi di specializzazione di storia islamica medievale in lingua araba alla Cairo University e ha frequentato le università di Ayn Shams (Cairo, Egitto) e Muhammad V (Rabat, Marocco). L’ambito di ricerca è la storia islamica medievale, con particolare attenzione alla storiografia araba contemporanea delle crociate e alla manualistica militare nell’Islam medievale. Relatore di Islamistica alla Facoltà Teologica “S. Bonaventura” (Roma) nel 2016, è socio dell’Istituto per l’Oriente “Carlo Alfonso Nallino” e di MESA (Middle East Studies Association).
Ha curato e tradotto dall’arabo il trattato Consigli sugli stratagemmi di guerra (Il Melangolo, 2013) di al-Harawī, oltre ad aver pubblicato interventi su diverse pubblicazioni scientifiche del settore. Il libro di Graphe.si avvale della sua traduzione della Cronaca di Ṣalāḥ al-Dīn dal Wafayāt al-aʿyān di Ibn Khallikān. Dalla presentazione editoriale. 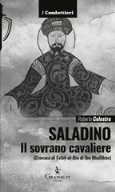 Salâh al-Dîn, noto come Saladino, è tra gli indiscussi protagonisti del XII secolo nello scacchiere mediorientale. La sua popolarità è ancor oggi senza eguali non soltanto nel mondo arabo, tanto da essere considerato vera incarnazione del cavaliere perfetto. Di origine curde, nacque a Tikrît nel 1138. Si mise in mostra quando nel 1163 partecipò alla spedizione nell'Egitto fatimide al seguito dello zio Shîrkûh, comandante dell'esercito del sovrano zenjide Nûr al-Dîn, conclusasi nel 1169. Morto improvvisamente lo zio, Salâh al-Dîn divenne prima visir (primo ministro) d'Egitto, quindi nel 1171 pose fine al califfato fatimide del Cairo. Alla morte di Nûr al-Dîn (1174), seppe diventare l'unico fautore dell'unificazione dei territori musulmani ponendo Siria, Egitto, Yemen e Mesopotamia settentrionale sotto la propria autorità. Nel 1177 si dedicò alla riconquista dei territori di Siria e Palestina ancora in mano ai crociati, sbaragliandone l'esercito il 4 luglio 1187 a Hattîn e riconquistando Gerusalemme il 2 ottobre. Nello scontro con Riccardo "Cuor di Leone", alla guida della terza crociata, fu sconfitto ad Arsûf e siglò il trattato di pace il 2 settembre 1192. Pochi mesi dopo, il 4 marzo 1193, Salâh al-Dîn si spense nella sua amata Damasco. Questa monografia si compone di un profilo biografico e della traduzione dall'arabo della Cronaca di Salâh al-Dîn tratta dal Wafayât al-a'yân di Ibn Khallikân (m. 1282), proposta per la prima volta in lingua italiana. Salâh al-Dîn, noto come Saladino, è tra gli indiscussi protagonisti del XII secolo nello scacchiere mediorientale. La sua popolarità è ancor oggi senza eguali non soltanto nel mondo arabo, tanto da essere considerato vera incarnazione del cavaliere perfetto. Di origine curde, nacque a Tikrît nel 1138. Si mise in mostra quando nel 1163 partecipò alla spedizione nell'Egitto fatimide al seguito dello zio Shîrkûh, comandante dell'esercito del sovrano zenjide Nûr al-Dîn, conclusasi nel 1169. Morto improvvisamente lo zio, Salâh al-Dîn divenne prima visir (primo ministro) d'Egitto, quindi nel 1171 pose fine al califfato fatimide del Cairo. Alla morte di Nûr al-Dîn (1174), seppe diventare l'unico fautore dell'unificazione dei territori musulmani ponendo Siria, Egitto, Yemen e Mesopotamia settentrionale sotto la propria autorità. Nel 1177 si dedicò alla riconquista dei territori di Siria e Palestina ancora in mano ai crociati, sbaragliandone l'esercito il 4 luglio 1187 a Hattîn e riconquistando Gerusalemme il 2 ottobre. Nello scontro con Riccardo "Cuor di Leone", alla guida della terza crociata, fu sconfitto ad Arsûf e siglò il trattato di pace il 2 settembre 1192. Pochi mesi dopo, il 4 marzo 1193, Salâh al-Dîn si spense nella sua amata Damasco. Questa monografia si compone di un profilo biografico e della traduzione dall'arabo della Cronaca di Salâh al-Dîn tratta dal Wafayât al-a'yân di Ibn Khallikân (m. 1282), proposta per la prima volta in lingua italiana.
Eccellente la cura degli apparati che contengono Glossario, Cronologia, Concordanza dei nomi di luogo, Indice dei nomi, Bibliografia. Segue ora un incontro con Roberto Celestre.
Saladino (2)
A Roberto Celestre (in foto) ho rivolto alcune domande.
Tra i tanti argomenti della storia islamica medievale perché hai scelto di trattare proprio la figura di Saladino? Che cosa ti ha particolarmente interessato in lui e su di lui?
 Saladino è senza dubbio una delle figure emblematiche del Medioevo e non soltanto nel mondo arabo musulmano, interprete di uno dei momenti di svolta nel confronto tra Occidente e mondo islamico, la cui personalità trascende gli eventi storici che lo videro protagonista. La sua personalità trovò fama anche nel mondo cristiano assurto a “nemico valente” da temere sui campi di battaglia, a cui corrispondeva una nomea di pari valore quale sovrano gentile e leale avversario. Tale trascendenza è alla base del mio interesse su Saladino, i cui lineamenti del carattere e del suo agire sono senza dubbio fuori dal comune, non soltanto per l’epoca in cui si svolsero gli eventi di cui fu partecipe e protagonista. Saladino è senza dubbio una delle figure emblematiche del Medioevo e non soltanto nel mondo arabo musulmano, interprete di uno dei momenti di svolta nel confronto tra Occidente e mondo islamico, la cui personalità trascende gli eventi storici che lo videro protagonista. La sua personalità trovò fama anche nel mondo cristiano assurto a “nemico valente” da temere sui campi di battaglia, a cui corrispondeva una nomea di pari valore quale sovrano gentile e leale avversario. Tale trascendenza è alla base del mio interesse su Saladino, i cui lineamenti del carattere e del suo agire sono senza dubbio fuori dal comune, non soltanto per l’epoca in cui si svolsero gli eventi di cui fu partecipe e protagonista.
Nello scrivere il tuo saggio qual è la cosa che hai deciso, ai fini di una corretta informazione, di evidenziare assolutamente per prima e quale quella per prima assolutamente da evitare? Nella stesura del mio libro ho cercato di rifuggire da una compilazione didascalica e per questo motivo la mia indagine ha attinto da numerose fonti in lingua araba, sia contemporanee sia classiche. Il saggio si compone di due parti, di cui la prima è una classica biografia redatta seguendo i canoni tradizionali in cui, oltre ai principali contributi della tradizione storica occidentale, ho voluto avvalermi anche degli studi contemporanei della scuola arabo musulmana che annovera spunti molto interessanti, purtroppo in larghissima parte non tradotti in lingue occidentali, poco conosciuti anche dagli specialisti del settore. Nella seconda parte del mio libro ho proseguito tale percorso, scegliendo di ricorrere a una fonte storica classica del XIII secolo di uno dei maggiori biografi musulmani, Ibn Khallikān di cui nel mio libro si troverà, per la prima volta in lingua italiana, la traduzione integrale della “Cronaca di Saladino”. In questo modo il lettore ha la possibilità di fare una lettura in parallelo tra la visione araba contemporanea di Saladino e quella a lui coeva, grazie ai rimandi presenti alla fine di ogni capitolo della prima parte che rinvia a quella corrispondente tradotta dall’arabo. Dal mio punto di vista, l’utilizzo di fonti in lingua araba ha lo scopo di avere anche una narrazione “di parte” e leggere la versione degli eventi secondo il punto di vista “dell’Altro”, non mediato dall’approccio storiografico occidentale che, seppur fondamentale, soffre di un’impostazione poco attento alla visione del mondo arabo-musulmano in materia. Saladino gode di citazioni benevole sia nel Convivio e nella Commedia di Dante sia nel Decamerone di Boccaccio, ma è pure vero che il suo nome in molte biografie è associato spessissimo all’aggettivo “feroce”.
Troppo buoni i primi o troppo severi i secondi? Saladino sfugge a qualsiasi schema interpretativo. Innanzitutto, era un curdo e non un arabo come molti erroneamente pensano. Per definire la sua magnanimità bisogna innanzitutto contestualizzare gli eventi, in un periodo in cui l’efferatezza era la regola. La magnanimità di Saladino aveva il precipuo scopo propagandistico di creare intorno a sé un’aurea di magnanimità e di tolleranza. Tale atteggiamento era in particolar modo mirato ai correligionari che egli inizialmente combatté per unire le popolazioni musulmane per poi di rivolgere il proprio sforzo militare contro la presenza dei Franchi in terra di Palestina. Anche se siamo lontanissimi dai minimi criteri di rispetto dei diritti dei prigionieri, bisogna sottolineare che la cattività aveva anche un costo per il mantenimento dei prigionieri nemici e ciò non era possibile in un’economia di guerra che dissanguò le risorse e le finanze della regione, in particolare durante la Terza Crociata. Ad ogni modo, le fonti sottolineano atti di estrema generosità da parte di Saladino che colpirono fortemente i contemporanei. Ad esempio, pagò con i propri averi il riscatto di quei cristiani, e furono tantissimi, che non avevano la possibilità di pagare la somma che avrebbe consentito loro di lasciare Gerusalemme (pena la schiavitù) dopo la sua conquista il 2 ottobre 1187 per opera dell’esercito di Saladino. Le fonti islamiche non nascondono che tale atteggiamento attirò gli strali dei consiglieri del sovrano ayyubide che lo avvisarono di dilapidare in tal modo il patrimonio personale, per di più pagando il riscatto a favore del nemico. Al contempo le fonti non nascondono l’atteggiamento inflessibile e cruento di Saladino verso i Templari, rei di efferatezze anche contro la popolazione civile musulmana.
La sua abilità di politico, di diplomatico fu pari, oppure no, a quella di stratega e guerriero? Saladino fu di tutto un po’. Certamente fu un abile politico e accorto diplomatico, riuscendo a coagulare intorno a sé tutte le forze musulmane, ricomponendo con fatica le tante divisioni interne che cento anni prima avevano facilitato la conquista di Gerusalemme (1099) da parte degli eserciti franchi venuti dall’Europa e l’insediarsi di stati crociati nel Levante. Fu anche un valente combattente, nonostante una clamorosa sconfitta a Montgisard (1177) per mano delle forze crociate guidate dal giovane sovrano Baldovino IV, durante la quale Saladino rischiò addirittura di morire. Altro caso fu la battaglia di Arsūf combattuta contro Riccardo Cuor di Leone. La storiografia occidentale la tramanda come una vittoria dei cristiani ma, visti i risultati sul campo di battaglia, in realtà possiamo dire che lo scontro si concluse con “un pari”. Il vero capolavoro di Saladino fu la vittoria di Hattin (1187) in cui egli non soltanto dimostrò di essere superiore sul campo rispetto al nemico, ma evidenziò in modo netto delle capacità strategiche, attirando l’avversario in una trappola da cui non riuscì a venir fuori, decretando il disastro delle armate cristiane che in quella battaglia perdettero in pratica tutto l’esercito
.
Che cosa significa il nome di Saladino nell’Islam di oggi? A distanza di ottocento anni dagli eventi che lo videro protagonista, Saladino vanta ancora una popolarità senza eguali in tutto il mondo musulmano. Per comprendere ciò bisogna meditare su cosa siano state le Crociate per il mondo musulmano e quali siano i riflessi nella storia contemporanea della regione. Non si può non essere d’accordo con lo storico israeliano Joshua Prawer che negli anni Settanta del secolo scorso definì la presenza di stati crociati nel Levante il primo esempio di colonialismo dell’Occidente in territori al di fuori del continente europeo. Oggi finalmente anche la scuola storica europea ne conviene. Da tempo siamo abituati a considerare storicamente le Crociate come un’estensione geografica del medioevo europeo, a differenza di quanto fa il mondo musulmano che vede in quell’esperienza una traumatica aggressione. Oggi il mondo musulmano fa un parallelismo tra la presenza di entità statali aliene, quali sono state quelle latine degli stati crociati, e la fondazione dello Stato d’Israele sorto all’indomani degli orrori dell’Olocausto a parziale compensazione da parte dell’Europa ai dolori e lutti subiti dal popolo ebraico. Il nocciolo della questione, se vogliamo brutalmente banale, è proprio questo e, per ironia della sorte, vi è una sottile coincidenza con la teoria dello storico israeliano Prawer. La popolarità di Saladino risponde a un desiderio delle masse arabo-musulmane di trovare una risposta alle divisioni interne al suo mondo e presentarsi così unito di fronte allo Stato d’Israele, percepito ancor oggi come entità aliena, proprio come lo erano stati i regni latini d’Oriente. Nel recente passato tale visione è stata strumentalizzata da autocrati locali autoproclamatisi leader del mondo arabo (Nasser, il presidente siriano Hafez al-Asad e Saddam Hussein, per citarne alcuni) che in realtà agivano per fini di propria legittimazione politica. Oggi la figura di Saladino continua ad essere oggetto di strumentalizzazione da parte dei movimenti radicali islamici che sembrano però dimenticare che la lotta di Saladino non si rivolse contro la fede cristiana, ma contro l’atteggiamento predatorio e colonialista dei Franchi venuti dall’Europa. ………………………. Roberto Celestre
Saladino
376 pagine * 18.euro
Graphe.it
Riscoperte
È in libreria pubblicata dalla casa editrice Scalpendi la prima monografia dedicata a Piero Persicalli.
In questo volume viene data finalmente al lettore la possibilità di scoprire la produzione artistica di Piero Persicalli (1886-1977) artista pressoché sconosciuto la cui vita venne segnata dall’esodo tra molti luoghi e da un’estesa rete familiare e sociale, la quale modellò il mondo interiore dell’artista e la sua pittura, costantemente sospesa tra la rappresentazione della realtà e la trasfigurazione simbolica di idee e sentimenti.
In grado di maneggiare diversi media e stili (dalla matita al carboncino, dalla sanguigna alla china, e anche disegnatore per tessuto), influenzato dai fenomeni dilaganti del giapponismo, dalla musica, dall’ideismo e dall’astrattismo, Persicalli ebbe come centri d’interesse costanti il mondo marino e quello popolare, spesso in intersecazione tra di loro Dall’introduzione di Francina Chiara laureata in Storia moderna all’Università degli Studi di Milano.  «È quantomeno curioso che un artista, di cui scrissero positivamente critici autorevoli, sia scomparso dall’orizzonte storiografico ed è perciò importante proporre alcune riflessioni a motivare l’oblio in cui è caduta la sua opera. Nato nel 1886 a Zara, Persicalli si formò a Monaco e Vienna dove le secessioni avevano rinnovato l’idea e la pratica dell’arte e seguito con coerenza la via, indicata da predecessori inglesi, dell’abbattimento delle barriere tra arte pura e decorativa. Dopo la Prima guerra mondiale soggiornò ed espose in Italia; negli anni Trenta visse e lavorò a Como, dove aprì uno studio di disegni per tessuti poiché la locale produzione tessile, nonostante la crisi economica internazionale scatenatasi dal 1929, poteva ancora offrire a un maestro d’arte, che aveva intrapreso la via dolorosa dell’esodo dalla Dalmazia, opportunità economiche tali da coltivare ancora – e insieme – la pittura senza inseguire il mercato. La sua opera non ha così subito una dispersione radicale, con indubbi vantaggi per lo storico dell’arte, sia per la disponibilità di un corpus di studio unitario e pressoché completo, sia per la mancanza dell’interferenza del mercato a condizionare una produzione concepita in sincera adesione alla passione di una vita e in risposta a bisogni e sentimenti espressi in libertà». «È quantomeno curioso che un artista, di cui scrissero positivamente critici autorevoli, sia scomparso dall’orizzonte storiografico ed è perciò importante proporre alcune riflessioni a motivare l’oblio in cui è caduta la sua opera. Nato nel 1886 a Zara, Persicalli si formò a Monaco e Vienna dove le secessioni avevano rinnovato l’idea e la pratica dell’arte e seguito con coerenza la via, indicata da predecessori inglesi, dell’abbattimento delle barriere tra arte pura e decorativa. Dopo la Prima guerra mondiale soggiornò ed espose in Italia; negli anni Trenta visse e lavorò a Como, dove aprì uno studio di disegni per tessuti poiché la locale produzione tessile, nonostante la crisi economica internazionale scatenatasi dal 1929, poteva ancora offrire a un maestro d’arte, che aveva intrapreso la via dolorosa dell’esodo dalla Dalmazia, opportunità economiche tali da coltivare ancora – e insieme – la pittura senza inseguire il mercato. La sua opera non ha così subito una dispersione radicale, con indubbi vantaggi per lo storico dell’arte, sia per la disponibilità di un corpus di studio unitario e pressoché completo, sia per la mancanza dell’interferenza del mercato a condizionare una produzione concepita in sincera adesione alla passione di una vita e in risposta a bisogni e sentimenti espressi in libertà».
Al libro ha curato le immagini Guido Cribiori un appassionato gallerista milanese che così dice: “É davvero bizzarro, dopo tanti anni passati ad occuparsi dell’arte del primo Novecento, imbattersi in un nome assolutamente sconosciuto che corrisponda ad una produzione artistica dello spessore di quella di Piero Persicalli. Si rimane per un attimo attoniti, chiedendosi come sia possibile, per poi passare ad uno stato di euforia scatenato dalla “scoperta”, perché di questo si tratta. La qualità pittorica, sublimata dalla enorme sensibilità dell’individuo, dà vita a cicli pittorici di raro lirismo ed eleganza, riscontrabili solo nei più importanti esponenti artistici del suo tempo”.
…………………………… Francina Chiara
Piero Persicalli
Opere 1907 – 1960
360 pagine * 48.00 euro
1000 immagini a colori
A cura di Guido Cribiori
Scalpendi Editore
lunedì, 18 novembre 2024
Arsenico e altri veleni (1)
Il veleno: sostanza che appare nella storia, nelle leggende, in letteratura e ancora al cinema, in testi teatrali, tanto per citarne uno forse imbattibile in primati è l’Amleto, ben tre avvelenamenti. Tra scena e fuori scena
Ma di morte per veleno ne è pieno il reparto, di ieri e di oggi.
Da Socrate condannato a bere la velenosa cicuta, perché accusato di corrompere i giovani e di non credere negli dèi a Gianna Nannini che vive un amore tossico “come un gelato al veleno”.
Il veleno, però, può essere contenuto anche in cose realmente piacevoli, anche nei sentimenti, perché nella farmacopea come nelle nostre vite è forse valida un’ammonizione che ci viene da una voce di circa cinque secoli fa, quella di Paracelso: «È la dose che fa il veleno». Uomini e donne, santi e assassini, animali fantastici, antidoti e amari calici, speziali e confidenti, crimini e processi. Ecco gli ingredienti di un libro splendido pubblicato dalla casa editrice il Mulino.
Titolo: Arsenico e altri veleni Una storia letale nel Medioevo.
L’autrice è Beatrice Del Bo.
Insegna Storia economica e sociale del Medioevo e Didattica della storia nell’Università degli Studi di Milano. Un suo recente libro con il Mulino è «L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo» (2023).
Per più estese informazioni bibliografiche CLIC
Che cosa promette, e mantiene, nelle pagine di questo suo saggio: “Troverete gli immortali, ma defunti, Romeo e Giulietta, i meno noti Simona e Pasquino, protagonisti di una novella del Decameron, e pure le undici galline di Antonio, vittime di una «lite condominiale» di quei tempi. E poi papa Benedetto XI, che nel luglio del 1304, dopo neppure un anno di pontificato, muore d’improvviso a Perugia e Ambrogina Demiano che compare tra i condannati nelle sentenze gridate dal giudice di Milano nel 1376”.
E tanto altro ancora, aggiungo io. Dalla presentazione editoriale.  «Nel Medioevo, il veleno era una minaccia costante, tanto che le morti per avvelenamento erano relativamente comuni, e l’arsenico, con la sua letale efficacia e la sua invisibilità, era una delle sostanze più micidiali. Le narrazioni letterarie, le cronache e le rappresentazioni artistiche hanno alimentato un immaginario del veleno come arma segreta e insidiosa e delle donne come le principali “avvelenatrici”. A partire dalle fonti storiche, Beatrice Del Bo decostruisce alcuni falsi miti di un fenomeno che ha affascinato e spaventato l’umanità per secoli: l’uso del veleno coinvolgeva uomini e donne di ogni ceto sociale, infiltrandosi tanto nelle corti nobiliari quanto nei mercati e nelle taverne delle città, e non era solo uno strumento di morte, ma anche di cura e un simbolo di autorità e controllo, capace di sconvolgere le dinamiche del potere e della vita quotidiana. La vera storia di un nemico spesso invisibile». «Nel Medioevo, il veleno era una minaccia costante, tanto che le morti per avvelenamento erano relativamente comuni, e l’arsenico, con la sua letale efficacia e la sua invisibilità, era una delle sostanze più micidiali. Le narrazioni letterarie, le cronache e le rappresentazioni artistiche hanno alimentato un immaginario del veleno come arma segreta e insidiosa e delle donne come le principali “avvelenatrici”. A partire dalle fonti storiche, Beatrice Del Bo decostruisce alcuni falsi miti di un fenomeno che ha affascinato e spaventato l’umanità per secoli: l’uso del veleno coinvolgeva uomini e donne di ogni ceto sociale, infiltrandosi tanto nelle corti nobiliari quanto nei mercati e nelle taverne delle città, e non era solo uno strumento di morte, ma anche di cura e un simbolo di autorità e controllo, capace di sconvolgere le dinamiche del potere e della vita quotidiana. La vera storia di un nemico spesso invisibile».
Il libro si avvale di illustrazioni e di un ricchissimo Indice dei nomi, dei veleni e degli antidoti Segue ora un incontro con Beatrice Del Bo.
Arsenico e altri veleni (2)
A Beatrice Del Bo (in foto) ho rivolto alcune domande. Incontrare una grande medievista quale lei è, ecco un’occasione troppo ghiotta per rinunciare alla domanda che segue.
Perché i pareri sulle date d’inizio e sulla fine del Medioevo sono spesso discordanti?  Le date sono frutto di esigenze umane, tanto psicologiche quanto didattiche: ci servono per organizzare le nostre conoscenze, per gestirle meglio, per memorizzare e per sentirci collocati nella Storia. In quanto tali, le date sono espedienti artificiali, tant’è che non tutte le persone adottano lo stesso sistema di datazione. Esse richiamano infatti eventi o snodi ritenuti epocali, che hanno determinato importanti cambiamenti, e quindi potenzialmente differenti da cultura a cultura. Nella storia medievale i mutamenti non sono mai stati repentini, per quanto incisivi, e perciò le date convenzionali lasciano il tempo che trovano. Per alcuni la data di inizio del Medioevo è il 395 d.C., anno di morte dell’imperatore Teodosio, per altri il 410, sacco di Roma di Alarico, re dei Visigoti, oppure il 496, quando Clodoveo, re dei Franchi, si convertì al cristianesimo e, per gli Spagnoli, può essere il 710, con la conquista araba. La data adottata comunemente in Italia è il 476, di solito accompagnata nei manuali dalla dicitura: “caduta dell’Impero romano d’Occidente”. Un’etichetta scorretta e fuorviante, poiché non si trattò di un evento fragoroso e circostanziato – una caduta! - che devastò la civiltà dei territori fino a quel momento sottoposti al governo romano, ma fu una molto meno catastrofica fine istituzionale di un regime politico già agonizzante; regime che, oltretutto, continuò ad operare per un altro millennio in Oriente, finché nel 1453 Costantinopoli non fu conquistata dagli Ottomani. Ed è questa la motivazione che ha indotto alcuni a scegliere proprio il 1453 come fine del Medioevo, anche perché coincide con la fine della Guerra dei Cent'Anni. Anche in questo caso i pareri non sono concordi poiché c’è chi ritiene più periodizzante il 1517, quando Lutero affisse le 95 Tesi, o il 1527, il Sacco di Roma dei Lanzichenecchi e potrei citarne altre, ma concludo con il 1492, la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, che è quella accettata dai più. Le date sono frutto di esigenze umane, tanto psicologiche quanto didattiche: ci servono per organizzare le nostre conoscenze, per gestirle meglio, per memorizzare e per sentirci collocati nella Storia. In quanto tali, le date sono espedienti artificiali, tant’è che non tutte le persone adottano lo stesso sistema di datazione. Esse richiamano infatti eventi o snodi ritenuti epocali, che hanno determinato importanti cambiamenti, e quindi potenzialmente differenti da cultura a cultura. Nella storia medievale i mutamenti non sono mai stati repentini, per quanto incisivi, e perciò le date convenzionali lasciano il tempo che trovano. Per alcuni la data di inizio del Medioevo è il 395 d.C., anno di morte dell’imperatore Teodosio, per altri il 410, sacco di Roma di Alarico, re dei Visigoti, oppure il 496, quando Clodoveo, re dei Franchi, si convertì al cristianesimo e, per gli Spagnoli, può essere il 710, con la conquista araba. La data adottata comunemente in Italia è il 476, di solito accompagnata nei manuali dalla dicitura: “caduta dell’Impero romano d’Occidente”. Un’etichetta scorretta e fuorviante, poiché non si trattò di un evento fragoroso e circostanziato – una caduta! - che devastò la civiltà dei territori fino a quel momento sottoposti al governo romano, ma fu una molto meno catastrofica fine istituzionale di un regime politico già agonizzante; regime che, oltretutto, continuò ad operare per un altro millennio in Oriente, finché nel 1453 Costantinopoli non fu conquistata dagli Ottomani. Ed è questa la motivazione che ha indotto alcuni a scegliere proprio il 1453 come fine del Medioevo, anche perché coincide con la fine della Guerra dei Cent'Anni. Anche in questo caso i pareri non sono concordi poiché c’è chi ritiene più periodizzante il 1517, quando Lutero affisse le 95 Tesi, o il 1527, il Sacco di Roma dei Lanzichenecchi e potrei citarne altre, ma concludo con il 1492, la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, che è quella accettata dai più.
E quali per lei sono quelle attendibili? Tutte e nessuna, a dire il vero. Mi piacerebbe più che altro che dessimo finalmente un nome a questa epoca, visto che ci ostiniamo a chiamarla “Medioevo”, cioè “Età di mezzo”. Si potrebbe definirla “Età del lume”, legandola a un elemento della cultura materiale che la connotò, ma sono aperta ad accogliere qualsiasi altra definizione che la indichi per le sue caratteristiche e non per la collocazione tra Antichità ed Età Moderna. Sulla periodizzazione, da storica dell’economia e della società, prediligo una periodizzazione più lunga, cioè l’età preindustriale, oppure più breve, tra due epidemie, la Peste di Giustiniano (541-542), l’ultima dell’Antichità per certi versi, e la Peste Nera, cioè il 1347-52, considerate le conseguenze che ebbero sulle strutture demografiche, economiche, politiche e sociali. In molte occasioni il Medio Evo è presentato (in romanzi, film, sceneggiati, fumetti, videogames e perfino in testi scolastici) come un’età fatta di secoli bui.
È un’epoca calunniata? Se sì oppure no, perché? È inverosimile pensare che quei mille anni siano stati connotati soltanto in senso negativo quindi la risposta è certamente: sì, è calunniata. Oggi contribuiscono alla fama negativa le voci dei mass media che impiegano spesso “Medioevo” e “medievale” come sinonimo di rozzo, ignorante, retrogrado, crudele, violento e chi più ne ha, più ne metta. Sicuramente la letteratura e il cinema, cartoni animati compresi, ma anche l’Illuminismo e, per certi versi, il Romanticismo, hanno contribuito alla costruzione di un Medioevo con tali caratteristiche e hanno fatto sì che si radicassero nell’immaginario comune. E benché storiche e storici abbiano scritto fiumi di inchiostro per ricostruire in maniera verosimile e accurata quel millennio, che ha avuto luci ed ombre come qualsiasi altro periodo storico, e durante il quale sono state molte le sperimentazioni, le scoperte, le innovazioni che ancora oggi fanno parte della nostra esistenza e la rendono migliore, dagli occhiali alle Università, per citarne soltanto due, gran parte delle persone si immagina un Medioevo con quei connotati negativi... … un’immagine artificiale… … sì, un’immagine artificiale che fa gioco però, e questo è il fenomeno più pericoloso, a coloro i quali oggi hanno bisogno di usare il Medioevo per scaricarsi dalla responsabilità delle efferatezze commesse da persone che vivono nella Contemporaneità e quindi riconducibili ai nostri assetti sociali. Un delitto orribile, un provvedimento che discrimina, una persona che agisce con modi brutali vengono infatti definiti medievali; è un meccanismo psicologico che aiuta a prenderne le distanze, a definire quelle atrocità come altro da noi. Invece siamo, ahimé! proprio noi i responsabili e non persone vissute mille anni fa… Sul mio profilo instagram @beatricedelbo ho aperto una rubrica #medioevoluminoso in cui raccolgo tutti gli articoli e tutti gli usi scorretti di Medioevo e medievale per sensibilizzare su questo tema… Nell’affrontare il tema di questo suo nuovo libro quale cosa ha deciso di fare assolutamente per prima e quale per prima assolutamente da evitare? Innanzitutto, ho verificato che ci fossero abbastanza fonti e variegate, anche materiali, per poterlo studiare fuori dai cliché, visto che Medioevo-veleno è un binomio molto praticato dalla letteratura e dal cinema ma lo è molto meno da storiche e storici. Mi serviva poter capire cosa le persone dell’epoca conoscevano a proposito di veleni, se li temevano e come si difendevano; desideravo poter raccontare un Medioevo che aveva un atteggiamento anche scientifico di fronte ai “tossici”, uscendo dagli antri delle “streghe” e dai pentoloni peni di zampe di rana e ali di pipistrello; narrare di medici e farmacisti al lavoro, di serpenti e rospi, contro i cui veleni esistono dei rimedi, di uomini che avvelenano i loro nemici ma anche le galline del vicino, e di donne che usano l’arsenico contro i loro mariti ma acquistandolo dallo speziale e non fabbricando pozioni… Ho evitato di farmi influenzare dai romanzi di successo, come il “Nome della Rosa”, che, peraltro, sono dichiaratamente opere di fantasia, e ho evitato di fermarmi allo studio di una tipologia soltanto di fonte, ma ho consultato processi, novelle, inventari di spezierie, trattati di medicina sui veleni, dipinti, cronache, resoconti di anatomopatologi ecc.
A sentire le voci e a leggere le pagine più diffuse sembra che il veleno nel Medio Evo sia amministrato in grande prevalenza da mani femminili. È proprio così? Per nulla ed è proprio la volontà di spazzare via questo cliché che mi ha indotta a scrivere il libro: ad avvelenare sono soprattutto uomini, e uomini potenti; ovviamente ci sono anche donne, soprattutto borghesi e popolari, ma dobbiamo fare attenzione alle nostre fonti perché alcune di quelle che troviamo nei processi accusate di avvelenamento, del marito soprattutto, possono essere vittime della società e delle testimonianze, visto che raramente possiamo “leggere” la loro voce, poiché spesso non si presentano in tribunale per rendere la loro testimonianza. Il veleno ai nostri giorni è ancora un’arma come un tempo o altri nascosti strumenti di morte ne hanno preso il posto? Nel Medioevo era facile intossicarsi, poiché erano molte le sostanze tossiche con cui si poteva venire in contatto involontariamente: dal veleno di serpenti, scorpioni, rospi e tarantole, alle erbe come la mandragola, l’elleboro e la belladonna, fino ai minerali come arsenico e argento vivo; molte di esse erano usate in medicina, altre nella tintoria, nella concia delle pelli, in pittura e nella cosmesi. Non posso dire, però, che fosse una cifra distintiva del Medioevo e che oggigiorno non vi siano produzioni industriali che nuocciono gravemente alla salute – abbiamo ben presente gli effetti dell’Eternit -, o prodotti di bellezza nocivi. E nemmeno posso affermare che oggi il veleno non sia usato per uccidere, poiché le cronache politiche recenti testimoniano il contrario. Ed è di pochi mesi fa la notizia di una giocatrice di scacchi che in Russia ha avvelenato con il mercurio la scacchiera per “spaventare” la sua temibile avversaria.
Purtroppo, oggi, rispetto al Medioevo, ci sono più armi subdole, batteriologiche, nucleari e chimiche, che possono procurare avvelenamenti di massa, benché questa pratica sia già attestata alla fine del Medioevo, adottata da papa Alessandro VI per eliminare l’esercito del re di Francia Carlo VIII.
………………………………. Beatrice Del Bo
Arsenico e altri veleni
304 pagine * 17.00 euro
e-book euro 11,99
Formato: ePub
Il Mulino
venerdì, 15 novembre 2024
Eretici a Milano
Prima di presentare il libro di oggi credo sia opportuno soffermarsi su di una parola che non pronunciamo tutti i giorni al bar: Pataria.
Mano al Dizionario: “Movimento politico-religioso di carattere ereticale e pauperistico, sorto a Milano nella seconda metà del sec. XI: le sue caratteristiche democratiche ne fecero un modo di affrancamento delle classi socialmente inferiori dai vincoli feudali. Nata dall'opposizione all'arcivescovo Guido da Velate, eletto per volontà dell'imperatore Enrico III (1045), la pataria espresse le istanze del clero e del popolo milanese contro la simonia.  La parola “pataria” la troviamo nelle pagine di un eccellente libro pubblicato dalla casa editrice Mursia e da pochi giorni in libreria. La parola “pataria” la troviamo nelle pagine di un eccellente libro pubblicato dalla casa editrice Mursia e da pochi giorni in libreria.
Titolo Eretici a Milano Quando la gente cominciò a voler dire la sua.
L’autore è Paolo Golinelli.
Già professore ordinario di Storia Medievale all’Università degli Studi di Verona, si occupa principalmente dei rapporti tra religione e società nel Medioevo.
Con Mursia ha pubblicato: “Matilde e i Canossa” (2004), “Celestino V” (2007), “Il Medioevo degli increduli” (2009), “Medioevo Romantico” (2011), “Terremoti in Val Padana (2012), “Un millennio fa. Storia globale del pieno Medioevo” (2015), “Breve storia di Matilde di Canossa” (2015) e “Santi e culti dell’anno Mille” (2017).
Qui in questo video una sua lectio su Matilde di Canossa che nella storia del Medioevo è una delle figure femminili più significative e alla quale Golinelli ha dedicato valorosi studi.
Questo suo nuovo saggio affronta un tema tra i più spinosi nel dibattito non solo nell’ambiente ecclesiastico di ieri perché ha avuto riflessi anche nel più ampio panorama culturale di quell’epoca: eresia.
È questa tra l’altro una parola antica che vive tuttora (anche se spesso virgolettata) applicata perfino a coloro che pur aderendo ad una ideologia politica o teoria estetica, a parere dei capi di un Partito o di una Corrente artistica, si allontanano dai dettami teorici di quella stessa organizzazione o tendenza cui appartengono.
L’eresia, però, è qui per Golinelli la base per migliorare la società, con il non conformismo, la partecipazione e le scelte consapevoli. Dalla presentazione editoriale «È necessario che anche le eresie ci siano» (I Cor. XI, 19). Partendo da questa frase di San Paolo, si ripercorrono i movimenti religiosi che interessarono l’Europa nel secolo dell’anno Mille. Si trattò di un risveglio delle coscienze che coinvolse gruppi sempre più numerosi di persone, che per la prima volta presero posizione contro la Chiesa feudale e un clero ritenuto indegno del ministero che professava. Questo è particolarmente evidente a Milano, una città in piena crescita economica e politica, dove si manifestò il movimento della Pataria, che fu il segno più palese di una nuova autoconsapevolezza delle persone, foriera di conseguenze per i secoli che seguirono.
Nella storia capita a volte che ciò che prima era accettato come naturale, improvvisamente viene messo in discussione. Se non si considerano questi elementi “dal basso” si perde un momento essenziale dei fenomeni storici: quelli che vengono dalle eresie».
…………………………… Paolo Golinelli
Eretici a Milano
212 pagine * 18.00 euro
Mursia
mercoledì, 13 novembre 2024
Qui ma non ora
Mi piace il lavoro di Giuliana Cunéaz e, infatti, anni fa le dedicai una puntata di Nadir una sezione di questo sito. Ora la Galleria Gagliardi e Domke di Giuliana Cunéaz ospita la terza mostra personale che si svolge nei suoi locali.
Viene esposta La belle au bois dormant (2023), installazione concepita come una macchina dei sogni che consente allo spettatore di sognare a occhi aperti attraverso un’esperienza immersiva individuale. Estratto dal comunicato stampa.  «Ciascuno, sdraiandosi su un letto realizzato dall’artista con un pattern che evoca l’universo tecnologico, si trova di fronte alla propria visione proiettata su un monitor inserito nella parte superiore del baldacchino: lo spettatore innesca un processo scrivendo una frase su un tablet, che viene rielaborata in base ad alcuni input che per mezzo dell’intelligenza artificiale vengono tradotti in emozioni reali. In sintonia con il tema guida di Artissima The Era of Daydreaming l’installazione giunge a Torino dopo essere stata esposta a Milano, Parma, al Labirinto della Masone e a Rimini. Il titolo dell’opera si riferisce alla celebre fiaba di Charles Perrault La bella addormentata nel bosco, con la differenza che qui si chiede allo spettatore di non addormentarsi lasciandosi trasportare in un universo onirico. Segno e sogno trovano infatti una loro sintesi formale in base a un metodo innovativo dove l’artista intreccia la sua poetica con le tecnologie più sofisticate. «Ciascuno, sdraiandosi su un letto realizzato dall’artista con un pattern che evoca l’universo tecnologico, si trova di fronte alla propria visione proiettata su un monitor inserito nella parte superiore del baldacchino: lo spettatore innesca un processo scrivendo una frase su un tablet, che viene rielaborata in base ad alcuni input che per mezzo dell’intelligenza artificiale vengono tradotti in emozioni reali. In sintonia con il tema guida di Artissima The Era of Daydreaming l’installazione giunge a Torino dopo essere stata esposta a Milano, Parma, al Labirinto della Masone e a Rimini. Il titolo dell’opera si riferisce alla celebre fiaba di Charles Perrault La bella addormentata nel bosco, con la differenza che qui si chiede allo spettatore di non addormentarsi lasciandosi trasportare in un universo onirico. Segno e sogno trovano infatti una loro sintesi formale in base a un metodo innovativo dove l’artista intreccia la sua poetica con le tecnologie più sofisticate.
“La belle au bois dormant” è un’opera realizzata con il sostegno di Var Digital Art e la consulenza tecnica di Roberto Beragnoli. Alla parete, alcuni di questi esiti completano l’esperienza installativa offrendo la visione di opere inedite del ciclo dei Sogni che consentono un ulteriore coinvolgimento emozionale dello spettatore.
Come recita il titolo della mostra, Qui ma non ora è una suggestione che ci costringe a ripensare a noi stessi e al continuo scarto temporale e spaziale a cui siamo sottoposti. L’indagine di Giuliana Cunéaz, che da più di vent’anni usa la tecnologia come supporto espressivo attraverso molteplici sperimentazioni, supera la dimensione fisica in una continua ricerca verso una prospettiva altra, tanto che il percorso di visita prosegue con l’esposizione di una serie di opere realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata dedicata agli Spiriti Guida degli animali (2024) intesi come numi tutelari. In questo caso l’artista ci pone di fronte a opere enigmatiche dove le immagini di animali rappresentano la sintesi di un processo più articolato dove ciascun soggetto, una volta inquadrato da uno specifico QR code, si trasforma sul proprio smartphone in un’animazione in realtà aumentata che incarna lo Spirito Guida. Dall’installazione “La belle au bois dormant” agli Spiriti Guida degli animali appare evidente come Giuliana Cunéaz in questa ultima fase del suo lavoro abbia saputo adattare ancora una volta le più attuali soluzioni tecnologiche a un processo di carattere emozionale».
…………………………………........ Giuliana Cunéaz
Qui ma non ora
Galleria Gagliardi e Domke
Via Cervino 16, Torino
Info: 011- 197 000 31
30 ottobre 2024 - 24 gennaio 2025
lunedì, 11 novembre 2024
Santi e bevitori
L’irriverente Coluche amava ripetere nei suoi recital: "Gesù trasformava l’acqua in vino.
Mi stupisce che solo in dodici lo seguissero dappertutto".
Che il vino, aldilà di quei famosi 12, abbia un fascino straordinario è fuori discussione.
Prima d’inoltrarmi in questa nota che del vino parla bene, ho il dovere sociale di segnalare quanto dice sull’alcol l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in sigla OMS (da me colpevolmente inascoltata) sull'alcol.
Dopo la voce dell’Oms, voglio proporre anche un’altra voce a me più vicina, quella del filosofo Edward Slingerland:”Nella brutale competizione fra gruppi culturali da cui emersero le civiltà, sono stati i bevitori, i fumatori e gli sballati a uscirne vincitori“.
Basta con le premesse, ed ecco il libro che presento oggi; ha a che fare, l’avrete già capito, con bevute e bicchieri.
Lo ha pubblicato la casa editrice Adelphi è intitolato Santi e bevitori Un viaggio alcolico in terre astemie.
L’autore è Lawrence Osborne che già figura da anni con molti titoli nel catalogo Adelphi.
Nato nel 1958 in Inghilterra, vive e lavora a Bangkok.
Dopo gli studi a Cambridge e Harvard, ha vissuto per un decennio a Parigi (città alla quale ha dedicato il saggio Paris dreambook).
Dal suo esordio nel 1986 con Ania Malina, ha scritto romanzi, racconti di viaggio, saggi (tra cui uno sulla Sindrome di Asperger, uno sull'etnologia e uno sul rapporto tra eros e thanatos). Giornalista, scrive per il New York Times, il New Yorker e l'Independent.
Nel 2021 ha vinto il Premio Targone Dorrick con “Nella polvere”.  “Santi e bevitori” è un libro che, divertendo chi lo legge, come accade a molte cose che hanno un aspetto giocoso - come lo hanno le pagine di Osborne - espongono faccende serissime: Qui alla ribalta due concezioni della vita che abbiamo noi umani. Non ci divide solo una questione di gusto del palate o un modo di passare il tempo, ma qualcosa che viene da un lontanissimo passato. “Santi e bevitori” è un libro che, divertendo chi lo legge, come accade a molte cose che hanno un aspetto giocoso - come lo hanno le pagine di Osborne - espongono faccende serissime: Qui alla ribalta due concezioni della vita che abbiamo noi umani. Non ci divide solo una questione di gusto del palate o un modo di passare il tempo, ma qualcosa che viene da un lontanissimo passato.
Ben vengano le tante barzellette o altre storie che inducono al riso illustrando episodi buffi con protagonisti ubrachi o astemi. Senza dimenticare, però, che la questione è colorata di rosso che in questo caso non è il colore di un vino. Basti pensare che l’autore nelle prime pagine del volume ricorda episodi truci: Solo è il nome della città di provenienza degli attentatori di Bali: il posto dove fervide scuole coraniche predicano il jihad contro l’industria indonesiana del turismo. Il gruppo Jemaah Islamiyah,collegato ad al-Qaida, ha organizzato due attentati esplosivi al Jw Marriott di Giacarta: il primo nel 2003, il secondo il 17 luglio 2009. Il Jw di Giacarta era famoso per il suo bar sensazionale, ritrovo della mondanità. Diciannove morti. Nel 2002 lo stesso gruppo ha fatto esplodere due bombe all’interno del Paddy’s Pub e davanti al Sari Club di Kuta, a Bali, uccidendo duecentodue persone. Nel 2005 ha ripetuto l’impresa tra alcuni ristoranti di Kuta e warung (baracchini che servono birra) di una località balneare frequentata dagli occidentali: Jimbaran. Sono rimaste uccise venti persone, molte da schegge e cuscinetti a sfera introdotti negli ordigni.
Per curare l’alcolismo c’è chi si fa ricoverare in una struttura specializzata, chi si affida a una terapia farmacologica, chi ancora pratica una ferrea astinenza. Lawrence Osborne ha una ricetta più originale: intraprendere un viaggio nel mondo islamico per studiare come vivono gli astemi e scoprire se da loro si può imparare qualcosa. L’esperienza sarà illuminante, temeraria e – per la gioia di noi lettori – sempre irresistibilmente spassosa. Accompagneremo Osborne a caccia di una birra a Surakarta, presidio indonesiano di al-Qaida, dove, sotto un ritratto di Osama bin Laden, un gruppo di studenti biancovestiti cercherà di convincerlo che l’alcol è «una maattia dell’anima». A Mascate lo seguiremo nell’affannosa ricerca di una bottiglia di champagne per brindare al nuovo anno, mentre la sua vita di coppia sperimenta impreviste dinamiche dettate dalla sobrietà forzata. E trepideremo per lui a Islamabad, quando si lancerà nella sconsiderata «avventura culturale» di ubriacarsi «in uno dei paesi più pericolosi e ostili all’alcol» della terra. Ma, davanti a un bicchiere, tutto il mondo è incline al paradosso: prova ne sono le cosiddette dry towns del New Jersey o certi sobborghi inglesi, dove fino a pochi decenni fa la «cultura suburbana dell’alcol» era l’antidoto alla «cultura urbana della droga». E al termine di questo rocambolesco tour ci apparirà lampante che lo scontro di civiltà tra Oriente e Occidente altro non è che il riflesso di due approcci diametralmente opposti alla vita – temperanza e sregolatezza, continenza e dissolutezza, con i loro paladini, astemi e bevitori, per sempre affiancati «in uno spirito di reciproca incomprensione». Per leggere alcune pagine di “Santi e bevitori”: CLIC! https://www.adelphi.it/download/13984/db589e85f9b9/osborne_santi-e-bevitori_casi_153_pp-202.pdf ……………………………………... Lawrence Osborne
Santi e bevitori
Traduzione di Mariagrazia Gini
202 pagine * 19.00 euro
Adelphi
venerdì, 8 novembre 2024
Cronaca di un attimo
Esistono autori di cinema non conosciuti dal grande pubblico ma che hanno prodotto lavori che suscitano angoli di memoria perfino se sono fotografate persone o fissati sguardi su paesaggi a noi sconosciuti.
È il pensiero, ad esempio, di Semir Zeki fondatore dell’Istituto di Neuroestetica, con base a Berkeley, in California.
Delicatezza delle inquadrature, abilità del montaggio restituiscono con la cipria del tempo emozioni e emotività.
In pratica: l’identificazione della sfera affettiva ed emozionale in contrapposizione a quella razionale, come avviene nei film di Enrico Bellodi scomparso prematuramente.
Verranno proiettati sotto il comune titolo di “Cronaca di un attimo”, al MUVI di Viadana (Via Manzoni 4) domenica 10 e 24 novembre 2024 alle ore 16:30.

Le opere sono state concesse da Lorenza Arrighi moglie di Bellodi.
Sono filmati inediti della Viadana degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso quelli che passeranno sullo schermo nel primo di questi due incontri novembrini. Istanti rubati, attimi di vita vissuta sono quelli ripresi da Bellodi e ora mostrati postumi.
Ha scritto Luigi Meneghelli della Cineteca bolognese “Mi piace il tocco sempre molto personale e fantasioso, sofferto ma anche con momenti di leggerezza di questi film
Se queste proiezioni sono oggi possibili è anche grazie alla Fondazione Cineteca di Bologna, che ha provveduto alla digitalizzazione delle opere.
In questi due incontri organizzati da Apeiron APS ognuno dei filmati, della durata di 15/20 minuti ciascuno, sarà commentato da esperti d’arte, storia e cinema. Più precisamente da Luigi Bonfetti Sabbioni – Luigi Malaspada – Afro Somenzari.
A proposito di quest’ultimo, artista patafisico e fondatore con la scrittrice Lorenza Amadasi di Fuoco Fuochino, (è lui all'origine di questa mia segnalazione delle proiezioni al Muvi) segnalo l’uscita più recente di una raccolta di acuti aforismi di Jacopo Narros con il titolo “Aforismi in punta di piedi” e la delicata composizione in versi “La farfalla" di Patrizia Grossi.
Le edizioni di FUOCOfuochino in venti esemplari sono tutte esaurite. A chi fosse interessato ogni edizione viene ristampata con il nome del richiedente in colophon, quindi praticamente un pezzo unico dedicato (Euro 15,00).
mercoledì, 6 novembre 2024
Scienziate
Dobbiamo essere grati ad Eva che si lasciò tentare dal serpente, mordendo, e, secondo una nota cronaca, facendo mordere ad Adamo, il frutto dell’Albero della Conoscenza che Dio aveva proibito.
Ha scritto la grande Margherita Hack: “La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l'universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l'insegnamento calato dall'alto, in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede”.
Rita Levi Montalcini: "Geneticamente uomo e donna sono identici. Non lo sono dal punto di vista epigenetico, di formazione cioè, perché lo sviluppo della donna è stato volontariamente bloccato".
Ha scritto Norberto Bobbio “Sono convinto da tempo che l’unica rivoluzione che potrà cambiare il mondo è quella femminile”.  La casa editrice Raffaello Cortina ha pubblicato un saggio che mette in luce dieci scienziate che hanno dato importanti contributi alle Scienze. La casa editrice Raffaello Cortina ha pubblicato un saggio che mette in luce dieci scienziate che hanno dato importanti contributi alle Scienze.
Titolo: Scienziate Storie di vita e di ricerca
L’autrice è Elena Cattaneo.
Professoressa ordinario di Farmacologia all’Università di Milano. È nota per gli studi sulla Còrea di Huntington, sulla quale lavora con l’obiettivo di rallentarne il decorso o bloccarne l’insorgenza. Il 30 agosto 2013 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente Giorgio Napolitano.
Nelle edizioni Cortina ha pubblicato Armati di scienza (2021)
Il libro in apertura presenta una conversazione con Camilla Gaiaschi: ha conseguito un dottorato in sociologia presso l’Università degli Studi di Milano dove è stata successivamente assegnista di ricerca e docente del corso “Pari Opportunità e Carriere Scientifiche”
Quali sono le scienziate che Elena Cattaneo presenta nel suo saggio?
Eccole, così riportate dall’Indice
1 Mariafelicia De Laurentis, astrofisica all’orizzonte degli event
2. Simona Lodato, neuroscienziata che sfida il cervello umano
3. Miriam Melis, elettrofisiologa innamorata della scienza sperimentale
4. Alessandra Gentile, arboricoltrice che studia come proteggere i frutti del Mediterraneo
5. Costanza Miliani, chimica fuori dai canoni
6. Cătălina Oana Curceanu, la scienziata che mette in crisi (o forse no) la fisica quantistica
7. Alessandra Mascaro, per imparare dagli scimpanzé l’importanza di prendersi cura
8. Maria Giovanna Durante, ingegnera “modello” che studia la scienza sotto i nostri piedi
9. Silvia Ferrara, filologa-investigatrice dei segni dell’umanità
10. Vincenza Colonna, genetista che legge i segreti del libro della vita Dieci storie, dieci vite, dieci esempi di donne coraggiose che rivelano quanto torto abbia un Dottore della Chiesa, qual è San Tommaso d’Aquino, che così scrive “La donna è fisicamente e spiritualmente inferiore (…) Essa è addirittura un errore di natura, una sorta di maschio mutilato, sbagliato, mal riuscito”. Dalla presentazione editoriale di Elena Cattaneo. «‘‘Da oltre trent’anni dedico la mia vita alla ricerca su una malattia neurodegenerativa ereditaria, la Còrea di Huntington. L’Italia è disseminata di storie di ricerca e di passione simili alla mia. Questo volume è il racconto di storie di scienza, di studiose e delle loro domande. Attraverso le voci delle protagoniste accompagnerò i lettori nell’esplorazione di ambiti di studio molto diversi, dalle lingue antiche all’astrofisica passando per la vita degli scimpanzè, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza collettiva sul contributo delle tante scienziate alla crescita culturale, scientifica, sociale del paese. Credo che le storie tracciate in questo libro rappresentino una rivoluzione in corso, l’inizio di un cammino che libererà le ragazze da zavorre e pregiudizi che in passato ne hanno impedito o rallentato i percorsi di emancipazione. Una rivoluzione in cui si moltiplicano quei modelli di riferimento che sono mancati a tante ragazze di ieri ma che mi auguro possano aiutare quelle di oggi e di domani a realizzare in pieno le loro aspirazioni». Per leggere un estratto: CLIC!
……………………………… Elena Cattaneo
Scienziate
208 pagine * 16.00 euro
E-book (Epub) 10.99 euro
Raffaello Cortina
lunedì, 4 novembre 2024
Letture cosmiche
Avviso per I cosmonauti che volano in Weblandia.
Sono tra i fans di Maria Teresa Carbone e non sono solo in questa eletta schiera.
Qualche cenno biografico, tratto dal webmagazine “Antinomie” al quale collabora. Forse non esaustivo delle sue attività. Per esempio, ricordo la conduzione con Nanni Balestrini di una trasmissione tv sui libri.
 Giornalista, autrice e traduttrice. Segue da anni l’editoria italiana e internazionale a cui dedica una rubrica sul quotidiano “il manifesto”, dove ha lavorato a lungo come redattrice culturale. Scrive di letteratura, fotografia e cinema per diverse testate, tiene corsi di giornalismo all’università di Roma Tre e per lo UCEAP (University of California Abroad Program), e si occupa di educazione alla lettura. Ha coordinato la redazione della rivista “alfabeta2”, ha diretto la sezione Arti del settimanale “pagina99”, ha organizzato alcune edizioni del festival “romapoesia” e tuttora cura rassegne sulla poesia italiana contemporanea. I suoi libri più recenti sono “Che ci faccio qui? Scrittrici e scrittori nell’era della postfotografia” (Italo Svevo 2022) e la raccolta di poesia “Calendiario” (Nino Aragno Editore 2020). Ha tradotto, tra le altre, opere di Joseph Conrad, Breyten Breytenbach, Zoë Wicomb, Ngugi wa Thiong’o, Paul Virilio, Virginie Despentes Giornalista, autrice e traduttrice. Segue da anni l’editoria italiana e internazionale a cui dedica una rubrica sul quotidiano “il manifesto”, dove ha lavorato a lungo come redattrice culturale. Scrive di letteratura, fotografia e cinema per diverse testate, tiene corsi di giornalismo all’università di Roma Tre e per lo UCEAP (University of California Abroad Program), e si occupa di educazione alla lettura. Ha coordinato la redazione della rivista “alfabeta2”, ha diretto la sezione Arti del settimanale “pagina99”, ha organizzato alcune edizioni del festival “romapoesia” e tuttora cura rassegne sulla poesia italiana contemporanea. I suoi libri più recenti sono “Che ci faccio qui? Scrittrici e scrittori nell’era della postfotografia” (Italo Svevo 2022) e la raccolta di poesia “Calendiario” (Nino Aragno Editore 2020). Ha tradotto, tra le altre, opere di Joseph Conrad, Breyten Breytenbach, Zoë Wicomb, Ngugi wa Thiong’o, Paul Virilio, Virginie Despentes
Ora ho appreso che è possibile leggere la Nostra su di una piattaforma che, forse, già conoscete: Substack.
Lì, quando le va, scrive una sorta di diario fatto di cose viste (città, film, libri spettacoli teatrali) o sentite (concerti, incontri, voci).
Cliccare QUIper leggere.
mercoledì, 30 ottobre 2024
Mangiare secondo la scienza
Anche i grandi possono dire delle baggianate, ad esempio, un giorno Socrate disse: “Ti pare che un vero filosofo possa curarsi di piaceri come quelli del mangiare e del bere?”.
Non sappiamo se questo suo dire fu l’ennesima causa dei rimproveri che gli muoveva la collerica moglie sua Santippe. In questo caso, però, mi sento di dare ragione alla signora.
Intervistai tempo fa il filosofo Nicola Perullo e gli chiesi il motivo dell’accostamento da lui fatto tra filosofia e alimentazione. Così mi fu risposto: “Mi sembra un avvicinamento naturale, quello tra gastronomia e filosofia. La complessità proposta dai problemi del cibo è enorme: il piacere, la fame, la cultura, l’industria, l’artigianato, la natura, la glocalizzazione e la salute”.
Ed ecco un libro che risponde soprattutto sul piano della salute su verità e miti che accompagnano il nostro cibo.
Un libro che consiglio non solo a chi si occupa delle cucine domestiche ma anche agli chef della nostra ristorazione.
Lo ha pubblicato la casa editrice Dedalo è intitolato Mangiare secondo la scienza La salute nel piatto.
L’autrice è Elisabetta Bernardi.
Nutrizionista, biologa, specialista in Scienza dell’alimentazione. Oltre vent’anni di esperienza nella comunicazione e nella ricerca scientifica applicata alla nutrizione. Autrice e conduttrice della rubrica “Scienza in cucina” per il programma televisivo scientifico “Superquark”, condotto da Piero Angela e “Noos” condotto da Alberto Angela.
È docente in diverse università, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e di libri divulgativi e coautrice di testi universitari  Scrive Alberto Angela in Prefazione: «Mangiare secondo la scienza è un libro che nasce da un’esigenza: esplorare il ruolo cruciale della nutrizione nella gestione della salute e delle malattie. Negli ultimi decenni, la ricerca scientifica ha dimostrato quanto profondamente la nostra dieta possa influire sul benessere generale, sulla prevenzione delle malattie e sulla gestione delle condizioni croniche. Questo volume colma il divario fra la complessità della scienza della nutrizione e gli innumerevoli consigli sulla dieta che spesso mancano di garanzie scientifiche (…) Uno degli insegnamenti di mio padre, cui Elisabetta dedica questo libro, era proprio il rigore scientifico e la semplicità del linguaggio: bisogna pensare di raccontare la scienza a persone che non sanno niente al riguardo e lei ha cercato di fare proprio questo. Ha navigato nelle banche dati delle pubblicazioni scientifiche per rendere facili e alla portata di tutti i risultati a volte complessi delle ricerche sulla nutrizione per contribuire a proteggere la nostra salute». Scrive Alberto Angela in Prefazione: «Mangiare secondo la scienza è un libro che nasce da un’esigenza: esplorare il ruolo cruciale della nutrizione nella gestione della salute e delle malattie. Negli ultimi decenni, la ricerca scientifica ha dimostrato quanto profondamente la nostra dieta possa influire sul benessere generale, sulla prevenzione delle malattie e sulla gestione delle condizioni croniche. Questo volume colma il divario fra la complessità della scienza della nutrizione e gli innumerevoli consigli sulla dieta che spesso mancano di garanzie scientifiche (…) Uno degli insegnamenti di mio padre, cui Elisabetta dedica questo libro, era proprio il rigore scientifico e la semplicità del linguaggio: bisogna pensare di raccontare la scienza a persone che non sanno niente al riguardo e lei ha cercato di fare proprio questo. Ha navigato nelle banche dati delle pubblicazioni scientifiche per rendere facili e alla portata di tutti i risultati a volte complessi delle ricerche sulla nutrizione per contribuire a proteggere la nostra salute».
Non è difficile immaginare che parecchi leggendo il titolo di questo libro storceranno il naso. Perché sono molti a sostenere che la scienza nulla c’entri con la cucina.
Erore direbbe Petrolini.
Credo che la migliore risposta si trovi in un profetico scritto del celebre cuoco francese Auguste Escoffier (1846-1935), il quale affermava già nel 1907 in Le Guide Culinaire: “La cucina, senza smettere di essere un'arte, diventerà scienza e dovrà sottomettere le sue formule, purtroppo ancora troppo empiriche, a un metodo e a una precisione che non lasceranno nulla al caso”.
Senza dimenticare che il celebre Pellegrino Artusi intitolò proprio “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene” (1891) quel suo famoso testo dalle innumerevoli edizioni.
Ai nostri giorni, ecco un grande cuoco qual è Gualtiero Marchesi dire: “La cucina è per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte”. Dalla presentazione editoriale. «Ho il colesterolo alto, quali alimenti devo prediligere? E per proteggere le mie ossa? Per prevenire il diabete devo limitare tutti gli zuccheri? Cosa fare con la pelle a buccia d’arancia? Il legame tra alimentazione e salute è molto stretto, perché noi siamo ciò che mangiamo e in questo modo forniamo all’organismo i mattoni per la sua rigenerazione continua. Ma un eccesso di alcuni nutrienti o un difetto di altri possono impedire al nostro corpo di reagire e difendersi dalle patologie che lo colpiscono. “Mangiare secondo la scienza” cerca di sfatare i miti che legano alcuni cibi all’insorgenza di determinate malattie, anche con esempi semplici come la sana abitudine di mangiare la frutta alla fine dei pasti. Tutto in coerenza con l’evidenza scientifica, citando solo gli studi fatti sull’uomo e non i risultati “preliminari” di ricerche condotte su animali o in vitro». Elisabetta Bernardi
Mangiare secondo la scienza
Prefazione di Alberto Angela
Pagine 212 * 17.00 euro
Dedalo
lunedì, 28 ottobre 2024
L'epoca delle idee cadute dal pero (1)
Ha un’aria molto soddisfatta di sé, gli occhi accesi di luce biblica, le parole si rincorrono via via accelerandosi, il fervore spumeggia, la donna accanto a quel suo profetico compagno annuisce soddisfatta. Chi è quel tale? Via, l’avete capito. È un odiatore della Scienza. Mi sta rivelando segreti di cui non sono degno d’esserne messo a parte visto che neanche un po’ m’emoziono.
L’11 settembre? Un inside job voluto dal governo degli Stati Uniti. Lo sbarco sulla Luna? Una finzione cinematografica. L’Aids? Un virus creato in laboratorio. Il riscaldamento globale? Una bufala. L’Olocausto ebraico? Un’esagerazione propagandistica. Il Covid? lo ha voluto Bill Gates alleato di Big Pharma. G5? Voluti, effetti devastanti sulla salute dell’uomo.
Del resto, ci sono i creazionisti che credono la Terra sia nata 6.000 anni fa e nel Medio Evo esistevano ancora i dinosauri. Costoro hanno largo seguito negli Stati Uniti e dispongono perfino di un museo.
E poi, com’è noto, la Terra è piatta.
Scrive Giorgio Vallortigara su Micromega: “Durante la pandemia da Covid-19 abbiamo anche assistito quasi in diretta al rapido sviluppo di vaccini che ci hanno permesso di superarla in tempi relativamente brevi. Eppure, mai come in questo periodo lo scetticismo nei confronti della scienza e degli scienziati galoppa” Un libro che espone i meccanismi psichici e sociali che portano alla diffusione di panzane purtroppo assai diffuse lo ha pubblicato la casa editrice Mimesis è intitolato L’epoca delle idee cadute dal pero Fake news, bufale e teorie del complotto: le origini del terrapiattismo della ragione.
Gli autori sono Edoardo Boncinelli e Antonello Calvaruso. Boncinelli (Rodi, 1941) è tra i maggiori genetisti italiani. Per più di vent’anni ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di genetica e biofisica del CNR di Napoli. È stato direttore del Laboratorio di biologia molecolare dello sviluppo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore della Scuola superiore Sissa di Trieste. Con Antonello Calvaruso ha ideato la neuroformazione. Tra le sue oltre cento pubblicazioni ricordiamo Il male (2007, 20192), Il principio di indeterminazione (2020), Che cosa abbiamo nella testa? (con A. Calvaruso, 2021) e La scuola della mente (2022). Calvaruso (Napoli, 1958) è bibliofilo, fotografo e navigatore per passione. Economista federiciano, specializzatosi negli anni ’80 in Analyses des donnes presso il Conservatoire national des arts et métiers di Parigi, ha insegnato disegni sperimentali, statistica e progettazione formativa presso vari Atenei, tra cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Con Edoardo Boncinelli è stato autore di Che cosa abbiamo nella testa? (2021). Dalla presentazione editoriale «Una delle domande che ci si pone più spesso in questo periodo è come sia possibile che circolino tante idee “cadute dal pero” in un’epoca in cui è così facile informarsi e aggiornarsi. Basta pensare alla teoria del terrapiattismo: nessuna base per sostenerla, migliaia di persone pronte a crederci. Per comprendere il fenomeno occorre indagarne l’origine e la diffusione. Sebbene nella maggior parte dei casi sia piuttosto complicato individuare la nascita di queste idee, è relativamente facile comprendere le modalità con cui esse si diffondono e si rafforzano. Edoardo Boncinelli e Antonello Calvaruso navigano nelle turbolente acque dell’ignoranza e del complottismo alla ricerca dei meccanismi di consolidamento e di espansione di una bufala». Segue ora un incontro con Edoardo Boncinelli.
L'epoca delle idee cadute dal pero (2)
A Edoardo Boncinelli (in foto) ho rivolto alcune domande.
Se le fosse richiesto di scrivere per un dizionario una nota sulla parola “ignoranza” come la comporrebbe? L’ignoranza, che secondo alcuni filosofi greci, è la cosa peggiore che possa esistere è associata a una scarsa conoscenza di cose che tutti sanno o di cose che sanno in pochi. In questa situazione, a proposito di certi argomenti, si ha una pericolosa commistione di conoscenza e ignoranza, L’ignoranza può essere diffusa e relativamente compatta e contemporaneamente si può riferire prevalentemente ad argomenti specifici.
Possiamo chiamare ignoranza attiva quella che nasce da una buona diffusione di cose delle quali si ignorano i principi e ignoranza passiva quel diffuso stato di disinteresse e distacco che si può generare anche in presenza di piccole offese alla conoscenza. Più vasta è la conoscenza meglio è con particolare riguardo a quella diffusa ma non possiamo fissare a priori questi parametri. Fermo restando che più cose si conoscono e meglio è. In un’epoca come la nostra dove l’informazione è diffusa su plurali mezzi, come mai era accaduto, attecchiscono tante “idee balorde” così nel libro sono definite le idee “terrapiattiste della ragione”…
È paradossale che in un’epoca nella quale si sanno tante cose e nella quale si può stare a contatto con minimi particolari di conoscenza, l’istruzione media delle popolazioni sia così bassa e poco aggiornata.
Fra le cose che si considerano frutto di ignoranza ce ne sono alcune che sono solamente frutto di scarsa conoscenza e di debole approfondimento. Molto di questo può accadere perché le cose che a ciò si riferiscono non compaiono così frequentemente: da una parte è facile venire a sapere di cose sempre nuove, magari già al tempo delle prime sedute sul seggiolone. Non è difficile che per alcuni argomenti si sappia qualcosa fin da bambini e che queste conoscenze siano difficili da perdere: esse rappresentano, quindi quasi, un patrimonio conoscitivo primario. Qual è la differenza fra “idee balorde” e “fake news” ?
La differenza sta tutta nella volontarietà ovvero se il soggetto sa o non sa che si parla di cose campate in aria: se lo sa si può parlare direttamente di malafede . Può indicare la conseguenza più grave di quelle idee sulla società? Nell’impostare la propria visione logica del mondo ciascuno cerca di rendere più accettabile e logico possibile quello che si ha da dire e di cui tutti parlano. Non c’è troppo inganno in questa posizione, quanto piuttosto un lasciarsi andare e una mancanza di rigore semantico che a lungo andare possono portare ad una concezione confusa e poco sequenziale di quello di cui si sa abbastanza poco (quello che io chiamo il marasma culturale). A tutti i livelli il lindore è più efficace delle pratiche di pulizia.
Il numero degli esempi che si possono portare è sconfinato, ma oltre al numero delle idee non proprio correttissime, va aggiunta la estrema variabilità di queste idee che operano creando confusione piuttosto che fare chiarezza. Che cosa fare per difendersi dal terrrapiattismo della ragione? È tutto fuor che semplice. Occorre riflettere sui nessi logici importanti che tengono in piedi una costruzione che traballa, piuttosto di una che si mantiene praticamente costante.
Un buon esempio di discussione e confronto, che con il tempo potrebbe diventare un antidoto alla diffusione di idee balorde, potrebbe essere rappresentato dalle modalità con cui la scienza affronta il problema della demarcazione tra ciò che è scienza e ciò che è pseudoscienza e aggiorna la verità scientifica attraverso il principio di falsificabilità. ……………………………………... Edoardo Boncinelli
Antonello Calvaruso
L’epoca delle idee cadute dal pero
234 pagine * 18.00 euro
Ebook - ePub/Mobi 12.99 euro
Mimesis
venerdì, 25 ottobre 2024
Surrealismi. Da de Chirico a Gaetano Pesce
È stato pubblicato il catalogo di una gran bella mostra allestita al Mart di Rovereto a cura di Denis Isaia da un’idea di Vittorio Sgarbi.
Occasione: centenario del movimento surrealista.
Titolo: Surrealismi da de Chirico a Gaetano Pesce.
“Surrealismi” al plurale perché gli italiani presenti esprimono, com’è scritto nel catalogo: ‘una pluralità di singole evidenze e di fronde di originale qualità e autonomia creativa, in costante dialogo con gli ambienti internazionali e con gli altri campi della cultura’.
Il curatore espone il profilo dell’esposizione in questo video.
In foto:  Valerio Miroglio, 1972, legno, materiale plastico, acrilico, cm 54 x 12, Archivio Pari&Dispari/Rosanna Chiessi. Valerio Miroglio, 1972, legno, materiale plastico, acrilico, cm 54 x 12, Archivio Pari&Dispari/Rosanna Chiessi. Accanto a nomi storici dei primi surrealisti la curiosità di Devis Isaia ha riaperto altri sentieri interrotti ritrovando Corrado Costa, Valerio Miroglio, Ugo Sterpini, Enrico Donati.
“Per ognuno” – estraggo dal catalogo – “è una rinascita, ma dentro un quadro definito che mai prima d’oggi era stato delimitato con Surrealismo italiano, in un percorso finalmente definito e rivelatore”.
Prendiamo ad esempio Valerio Miroglio del quale la Treccani dice: Artista originale e del tutto autonomo seppure vicino all’arte concettuale e al citazionismo, attraverso una continua sperimentazione di tecniche e materiali ha sviluppato una riflessione sul significato dell'arte e sul suo ruolo nella società.
Particolare interesse ha suscitato il suo Mappamondo (in foto). Il catalogo, edito dalla Sagep, riunisce le biografie di ciascuno dei circa 70 artisti presenti nell’esposizione e raccoglie i contributi di: Vittorio Sgarbi, Denis Isaia, Chiara Portesine, Concetta Leto, Giulia Tulino, Guido Pautasso, Lucio Scardino, Manuel Barrese, Paola Decina Lombardi, Roberta Serpolli. Surrealismi
Catalogo di 329 pagine
39.00 euro
Edizioni Sagep
Aldo Zargani in Bibliotheka
Mentre lavoravo in alcune produzioni Rai con l’attrice Elena Magoia un giorno mi presentò il marito Aldo Zargani
Scoprii un uomo intellettualmente raffinato, dalla parlata sommessa ed elegante, che io colpevolmente non conoscevo quale scrittore. Conobbi allora le sue pagine di memorie. Memorie sofferte durante le persecuzioni naziste, di cui, lui ebreo ne era stato testimone: la perdita del lavoro del padre violinista, l’esclusione dalle scuole, l’espatrio fallito, la fuga attraverso il Piemonte, l’arresto dei genitori, il collegio, la deportazione dei parenti. “Per violino solo”, suo primo libro, fu un successo. Dopo, soltanto una tiepida accoglienza accolse “Certe promesse d’amore” che ora troviamo in una nuova edizione per i tipi della casa editrice Bibliotheka. 
In foto: Aldo Zargani ritratto da Dino Ignani.
È accaduto che nel 2020, mentre la pandemia infuriava, Aldo ed Elena decidono di rivedere quel testo. Sembra un’impresa impossibile ma, scrive la figlia Lina nella postfazione, “Mia madre, la titanica se pur minuta metà della mela rimasta in rappresentanza, aveva le idee chiarissime su cosa potare e dove fare gli innesti, quasi tutte sacrosante: quel libro, anzi, tutti i libri, li scrivevano insieme: lui dalla sua James Longue Chair metteva in scena la dettatura, seguendo sul tablet quello che lei scriveva al computer, e i due alternavano liti furibonde a scrosci di risate, quanto si sono divertiti! Mia madre sapeva, per consonanza e per conoscenza, quali fossero le intenzioni di papà e le aveva sapute realizzare con sapiente rispetto, altroché”.
“Certe promesse d’amore” - dice Daniela Gloss sul webmagazine ‘Doppiozero’ in un suo attento e partecipato mini saggio, cui questa nota è debitrice di molte informazioni – è “l’ideale seguito di ‘Per violino solo: La mia infanzia nell’Aldiqua (1938-1945)’ che, dopo una carriera in Rai, a 64 anni era stato il suo fulminante debutto. In quel libro, forse il suo capolavoro, Zargani ricreava il periodo della Seconda guerra mondiale e le persecuzioni antisemite. Qui completa il racconto soffermandosi su un capitolo meno noto che rappresenta però uno snodo centrale negli anni della ricostruzione e nel ritorno alla vita dell’ebraismo europeo dopo la Shoah… Il mondo ha la memoria corta e oggi che l’antisionismo è diventato uno slogan di moda è facile dimenticare cos’ha significato, dopo la tragedia delle persecuzioni nazifasciste, la nascita di uno Stato ebraico". QUI un intervento di Aldo Zargani: ricordi amari scanditi da episodi narrati con toni umoristici.
|


